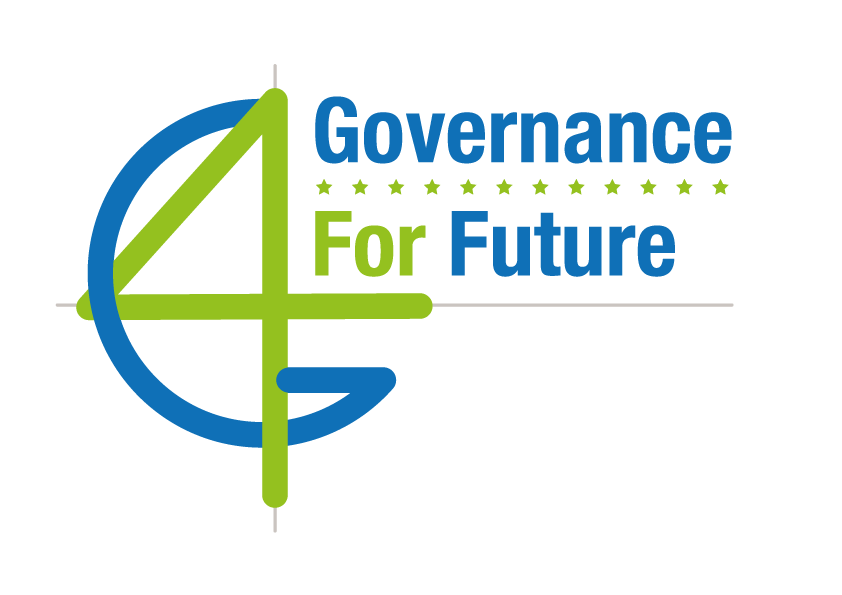Nelle situazioni di emergenza e post-emergenza la comunicazione tra istituzioni e cittadini è un fattore determinante per mitigare i danni: basti pensare all’impatto negativo degli avvisi di pericolo tardivi o inesistenti in casi di frane (Vajont, 1963), incidenti nucleari (Chernobyl, 1986) o epidemie (Covid-19, oggi). Occorre sottolineare che organizzazioni complesse come gli Stati moderni sono sempre alle prese con problemi di conflitti di competenza tra livelli di governo, aggravati dalla tendenza all’inerzia burocratica che caratterizza ogni organizzazione con procedure codificate minuziosamente e pensate per situazioni di normalità.
E’ quindi necessario ripensare la comunicazione istituzionale in due direzioni: a) per orientare correttamente i comportamenti dei destinatari delle decisioni, al fine di prevenire i rischi e ridurre i danni; b) per rassicurare i cittadini rispetto alle paure alimentate dal virus. Gli obiettivi fondamentali devono essere prevenire le reazioni irrazionali che tali paure possono suscitare, rafforzare la fiducia reciproca tra i soggetti che concorrono alla riuscita delle politiche e costruire fiducia verso i programmi.
Le due dimensioni, comportamenti e rassicurazione sono interdipendenti: quanto più la comunicazione è credibile tanto più sarà rassicurante e riuscirà a orientare scelte razionali. Solo in questo contesto gli esiti delle decisioni pubbliche potranno sperare di essere efficaci nel combattere la pandemia oggi, e altri incidenti nel futuro, riportando il sistema a un livello ‘accettabile’ di normalità.
Solo concependo la comunicazione come essenziale ‘servizio pubblico’ essa diventerà un efficace strumento di policy, complementare ad altri, per garantire la prevenzione e il contrasto agli effetti negativi di crisi sanitarie e pandemie come quella in atto.
Per capire se la crisi legata al Covid-19 ha contribuito a innovare la comunicazione verso i cittadini dobbiamo porci alcune domande:
- Chi comunica con i cittadini? Vi sono professionalità e tecniche ad hoc per la comunicazione in situazione di emergenza e post emergenza? O la comunicazione è appannaggio dei leader politici? La gestione della comunicazione verso i cittadini in tempo di crisi richiede una riflessione e metodologie specifiche? Non è chiaro quanto si stia riflettendo su questo aspetto, sembra piuttosto che l’improvvisazione tenda a prevalere su specifiche linee guida. Che ruolo hanno e potranno avere i media tradizionali e i nuovi social media? Durante la prima fase dell’emergenza i nuovi media hanno svolto un ruolo positivo nel creare una stabile connessione tra istituzioni e cittadini, ma nello stesso tempo hanno facilitato (com’era inevitabile) la diffusione di notizie contraddittorie che aumentavano la confusione.
- Come comunicare con i cittadini? Quali sono le strategie e gli strumenti utilizzati per orientare comportamenti e rassicurare, per diffondere e sostenere i vari programmi sanitari, scolastici, economici e di mobilità? Quali di queste strategie risultano più efficaci? Un aspetto rilevante in questa direzione è la chiarezza e coerenza dei contenuti informativi veicolati all’esterno.
- Che cosa comunicare ai cittadini? Qui il tema centrale è il tipo di informazioni e dati che devono e possono essere utilizzati per orientare comportamenti e rassicurare. Quanto la scienza medica e gli scienziati più in generale possono contribuire all’efficacia comunicativa e a quali condizioni? Quanto i leader si avvalgono dell’informazione provenienti dalla medicina e dalle scienze sociali nello sforzo di comunicare all’esterno gli effetti negativi del virus e le azioni di contrasto degli effetti collaterali sociali ed economici?
- Perché comunicare ai cittadini? Nelle finalità della comunicazione entrano in gioco interessi di politics rispetto alla prospettiva temporale delle policy per il contrasto all’emergenza stessa. Si comunica ai cittadini principalmente per compiacerli e ottenere simpatia e consenso alle prossime elezioni o si comunica per risolvere problemi ed essere efficaci rispetto a problemi reali? Si comunica guardando al breve periodo o al medio-lungo periodo?
- Quando comunicare ai cittadini? La tempistica in situazioni di emergenza è una misura della efficacia stessa della comunicazione. L’emergenza sanitaria sconvolge la vita pubblica e privata di ognuno, e gli effetti collaterali negativi dell’emergenza presentano aspetti di tempestività che possono compromettere l’efficacia dell’intervento pubblico. La tempistica della comunicazione che accompagna le decisioni e contribuisce a creare la narrazione a loro supporto è tanto più credibile quanto più è in sintonia con i tempi reali degli eventi, con i bisogni e gli interessi che caratterizzano le diverse fasi dell’emergenza.
Per concludere, vogliamo sottolineare come nei momenti di emergenza sia importante evitare la cacofonia di voci: ogni istituzione, nelle rispettive aree di competenza, deve parlare con una voce sola, fornire informazioni attendibili e indicazioni chiare. Solo in questo modo le istituzioni potranno garantire, ad un tempo, la credibilità necessaria ad operare e l’efficacia dei programmi.