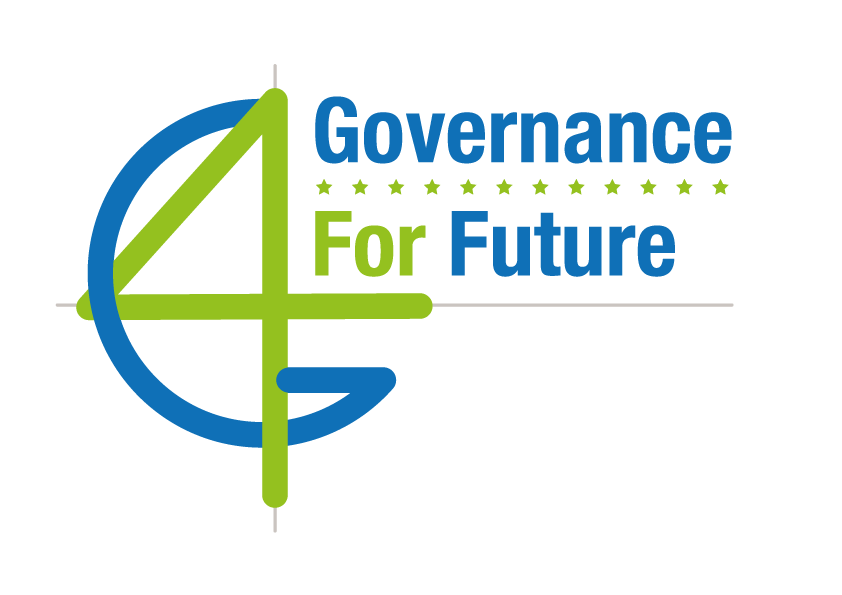Tra i pilastri che permettono il funzionamento della democrazia, fondamentale è la partecipazione popolare e le variazioni da parte dei cittadini rispetto a tale partecipazione sono spesso associate al sostegno o all’opposizione verso le istituzioni, ai valori e ai principi democratici.
Nelle dinamiche che coinvolgono questa partecipazione, gli studiosi di politica hanno rivolto negli anni un’attenzione particolare al coinvolgimento dei giovani, nello specifico nella fascia 18-34, poiché l’atteggiamento dei giovani nei confronti della vita politica è importante per comprendere quali valori e modelli di impegno democratico si creano e si cristallizzano nel corso del tempo.
Dall’inizio del secolo la tendenza sembra dimostrare un allontanamento dei giovani dalla politica, una “disaffezione democratica” soprattutto rispetto alle forme tradizionali di partecipazione politica, che si possono identificare soprattutto nel voto e nell’appartenenza a un partito.

Disaffezione, opposizione o nuovi modelli di partecipazione politica?
Lo scetticismo e la disaffezione verso le istituzioni democratiche vengono considerati parte di una crisi più ampia, che desta preoccupazione perché si ritiene che la minor partecipazione esponga le democrazie agli autoritarismi. Secondo altri punti di vista tuttavia, questa disaffezione appare come più una critica costruttiva che un rifiuto della democrazia.
Per comprendere in che modo i giovani sono inseriti all’interno delle dinamiche di partecipazione politica è utile capire cosa può influenzare le loro posizioni. L’entrata nel mondo del lavoro, la creazione di una famiglia sono particolarmente impattanti nel modellare l’impegno politico di una persona. Inoltre, anche le disuguaglianze legate a genere, origine e status socioeconomico influiscono ulteriormente, evidenziando differenze tra gruppi giovanili all’interno di diverse democrazie.
Le disuguaglianze economiche in particolare, si riflettono in atteggiamenti più critici verso la democrazia. Problemi come l’accesso limitato alla casa, i debiti studenteschi e i cambiamenti nel mercato del lavoro condizionano la disponibilità dei giovani ad investire in capitale umano e incidono sulle opportunità di crescita civica e sociale. Inoltre, la partecipazione dei giovani alla politica dipende anche dall’accesso a risorse e reti sociali, dalla presenza di atteggiamenti democratici, e dalla disponibilità ad agire. La mobilitazione anche internazionale è quindi fondamentale per garantire una rappresentanza efficace e preservare i beni collettivi.
L’impatto di queste disuguaglianze si manifesta in atteggiamenti critici verso la democrazia, modellati dalle diverse opportunità socioeconomiche che i giovani hanno incontrato. In particolare, le esperienze di turbolenze socioeconomiche durante gli anni della formazione possono avere effetti duraturi sulle opinioni democratiche e sull’impegno politico dei giovani, rendendo evidente l’importanza di considerare la varietà dei contesti giovanili nelle analisi della partecipazione politica.
La non partecipazione dei e delle giovani, più che un allontanamento, è un modo per dimostrare l’insicurezza delle generazioni più giovani verso i modelli democratici tradizionali che sembrano meno rispondenti ai loro bisogni. In particolare, i giovani stanno esplorando nuove forme di partecipazione politica, come l’attivismo digitale, la protesta, i flash mob o il volontariato, che superano le modalità consolidate e che spesso non vengono però compresi dalla popolazione più adulta, generando un cortocircuito. Questa generazione è vista anche come promotrice di cambiamenti sociali e politici attraverso movimenti e proteste su temi come il cambiamento climatico, il femminismo, le tematiche legate ai diritti lgbtq+, la giustizia sociale, spesso difficili da incanalare nelle istituzioni democratiche formali.
 L’esempio dei giovani in Europa
L’esempio dei giovani in Europa
Per cercare di comprendere questo fenomeno e andare oltre le semplici speculazioni, tra aprile e dicembre 2018 è stata condotta un’indagine finanziata dall’Unione Europea che ha coinvolto 27.000 giovani tra i 18 e i 34 anni provenienti da nove Paesi europei. L’indagine include un campione di giovani tra 18 e 34 anni di Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. L’indagine, condotta attraverso panel online, ha utilizzato quote bilanciate per sesso, età, regione e livello di istruzione, assicurando che il campione rispecchiasse la struttura demografica dei vari Paesi. Tra le variabili che influiscono sulla partecipazione democratica si è visto che ulteriori fattori di influenza sono anche l’eventuale background migratorio, la scolarizzazione, la zona eventuale di residenza, se urbana o meno.
Dall’analisi dei dati emerge che gli atteggiamenti di opposizione alla democrazia variano significativamente tra i gruppi di età, mostrando una complessità e una variabilità all’interno dei giovani stessi. In particolare, i risultati indicano una differenza significativa nell’opposizione alla democrazia tra le tre fasce d’età (18-24 anni, 25-34 anni e 35+ anni). I giovani tra i 25 e i 34 anni mostrano livelli più alti di opposizione rispetto ai 18-24 anni e, soprattutto, rispetto agli adulti oltre i 35 anni.