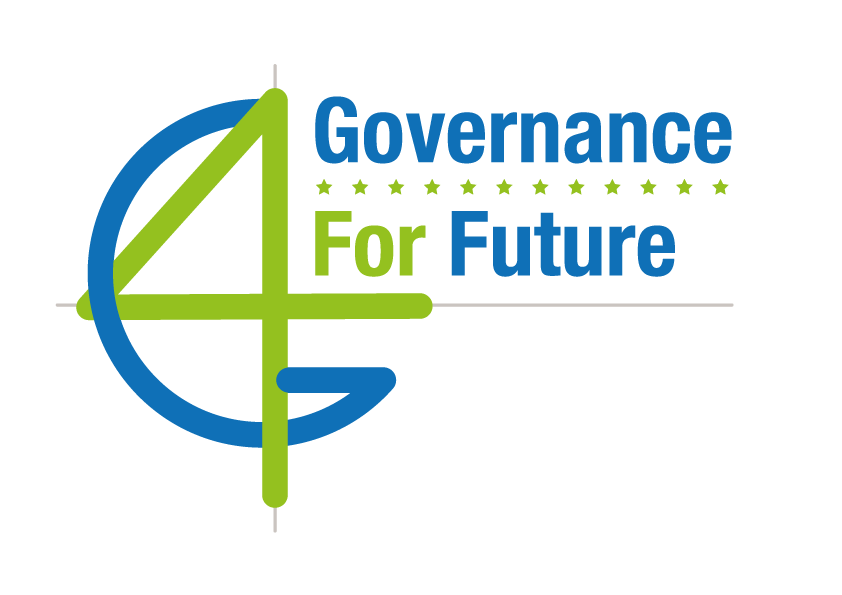La solidarietà intergenerazionale è un tema centrale per affrontare le sfide contemporanee, un concetto che si riferisce al legame tra le generazioni presenti e future. In un mondo caratterizzato da crisi globali come il cambiamento climatico, l’invecchiamento della popolazione e le disuguaglianze sociali, è essenziale considerare l’umanità come un’unica comunità temporale, dove le decisioni prese oggi hanno conseguenze durature nel tempo.
La riflessione su questi temi si arricchisce grazie all’adozione di un approccio basato sul concetto di specie umana. In biologia, la specie è intesa come una comunità di individui uniti da caratteristiche condivise e da un percorso evolutivo comune. Applicando questa nozione al campo giuridico, si può considerare l’umanità come un’entità in evoluzione continua, che include passato, presente e futuro, e che può essere un punto di partenza per ripensare i rapporti tra generazioni e le responsabilità delle une verso le altre.
Questa visione suggerisce che le generazioni attuali abbiano una responsabilità non solo verso i loro coetanei, ma anche verso i posteri. La solidarietà verso le generazioni future, in questa prospettiva, non è solo un obbligo morale, ma un elemento necessario per garantire la sopravvivenza e il benessere della specie nel lungo termine.
Diritti delle generazioni future: una sfida per il diritto
Uno degli aspetti più complessi della solidarietà intergenerazionale riguarda l’attribuzione di diritti alle generazioni future. Poiché queste non esistono ancora, non possono essere soggetti giuridici nel senso tradizionale. Tuttavia, le scelte compiute oggi hanno un impatto significativo sul benessere di chi verrà, sollevando la questione di come le generazioni attuali possano essere responsabili nei confronti di quelle future.
Il diritto tradizionale, basato sulla soggettività giuridica e sull’interazione tra individui esistenti, incontra difficoltà nel trattare temi che riguardano soggetti potenziali. Un possibile approccio consiste nel considerare il diritto come uno strumento per garantire la continuità della specie umana. Questa prospettiva permette di superare la dicotomia tra generazioni presenti e future, concependo l’umanità come un’entità collettiva che evolve nel tempo.
Oggi il problema dal punto di vista giuridico si pone anche in relazione a democrazia e liberalismo, concetti siano interconnessi ma anche in tensione. La democrazia, fondata sulla sovranità popolare, richiede limiti per evitare degenerazioni in dittature della maggioranza o anarchia. Il liberalismo, con il suo focus sulla libertà individuale, necessita di controlli per bilanciare gli eccessi dell’individualismo. La democrazia rappresentativa è stata storicamente un risultato del liberalismo, ma la crescente richiesta di maggiore partecipazione diretta (come i referendum popolari) evidenzia criticità come il rischio di decisioni antidemocratiche e l’influenza delle minoranze attive. Strumenti come la democrazia diretta e le tecnologie digitali possono aumentare la partecipazione, ma non risolvono le complessità strutturali del sistema democratico. Una visione bilanciata, basata sulla solidarietà e sul rispetto dei limiti, risulta quindi essenziale per preservare l’efficacia e la giustizia della democrazia.
L’equilibrio tra diritti e responsabilità: il caso della pandemia
Affrontare le responsabilità verso il futuro richiede un delicato equilibrio tra diritti individuali e obiettivi collettivi. Una delle sfide principali riguarda l’identificazione di limiti accettabili alle libertà personali per favorire il benessere generale e preservare risorse essenziali per le generazioni future.
Un esempio rilevante è rappresentato dalle politiche ambientali. Queste richiedono spesso sacrifici da parte delle generazioni attuali, come la riduzione delle emissioni di gas serra o la limitazione del consumo di risorse naturali, per preservare l’ambiente per chi verrà. Tali scelte possono essere percepite come restrizioni, ma riflettono una visione più ampia della giustizia, che include il benessere collettivo e transgenerazionale.
L’esperienza della pandemia di Covid-19 poi, ha offerto un contesto concreto in cui esplorare il concetto di solidarietà intergenerazionale. Le misure adottate per contenere la diffusione del virus, come il confinamento, il distanziamento sociale e la vaccinazione, hanno messo in luce il rapporto tra responsabilità individuale e protezione collettiva. Questi interventi hanno avuto l’obiettivo di proteggere non solo i singoli individui, ma anche le comunità nel loro insieme, incluse le generazioni più vulnerabili.
Uno dei problemi che queste restrizioni o imposizioni presentavano, era come garantire l’uguaglianza verso diverse categorie di soggetti, in modo da tutelare la salute di quante più persone possibile. Tuttavia, le misure previste comportavano, seppur per un fine più alto, la restrizione delle libertà individuali e andando in apparenza a confliggere con quanto previsto dalla Costituzione italiana. Del resto, il concetto di libertà porta con sé una serie di problematiche intrinseche, poiché l’uomo cerca continuamente di ridefinire i limiti della propria libertà.
L’applicazione di tali restrizioni ha polarizzato la popolazione italiana, con da una parte persone che hanno accettato (anche con spirito di sacrificio) di attenersi a quanto imposto, e dall’altra la creazione di gruppi che vi si sono fortemente opposti. In riferimento a questi ultimi in particolare, si sono creati gruppi di persone che la pensavano allo stesso modo e che cercavano informazioni o posizioni che dessero conferma alle proprie posizioni preconcette. La creazione di queste bolle ha fatto fiorire la rivendicazione del diritto di libertà secondo la loro visione che per molti è stata interpretata come individualistica o egoistica.
In questo caso, l’idea del concetto di libertà intesa come autodeterminazione non tiene conto del contesto sociale in cui è declinata, per cui effettivamente si presenta come una libertà egoistica e non solidale.
Dall’altro lato invece, l’accettazione di tali misure ha evidenziato come il benessere collettivo possa dipendere dalla capacità di ciascun individuo di contribuire alla sicurezza degli altri. Questo principio è applicabile anche alle generazioni future: le azioni intraprese oggi, come la lotta al cambiamento climatico o la gestione sostenibile delle risorse, possono garantire condizioni di vita migliori per chi verrà.

Fonte: Pexels
La solidarietà come fattore fondamentale di coesione nella società e tra le generazioni
La solidarietà è un elemento centrale di ogni società, poiché garantisce la coesione sociale e la continuità delle relazioni tra individui. Nel contesto intergenerazionale, essa si manifesta attraverso azioni che favoriscono il benessere delle generazioni precedenti, come i sistemi previdenziali, e attraverso misure che proteggono le generazioni future, come le politiche di sostenibilità.
La solidarietà poi, può essere declinata in due forme principali: spontanea e istituzionalizzata. Nella solidarietà spontanea ritroviamo comportamenti volontari, guidati da principi morali o etici. La solidarietà istituzionalizzata invece si traduce in obblighi giuridici e politiche pubbliche che regolano i rapporti tra individui e gruppi, includendo anche le generazioni non ancora presenti.
Una società quindi sarà più o meno solidale in base alle propensioni degli individui, a quanto questi saranno disposti a rinunciare in favore della collettività, ma se questo fosse l’unico requisito, sarebbe strettamente legato alla soggettività. Di conseguenza, perché venga garantita una soglia minima di uguaglianza tra tutti gli individui, saranno le istituzioni a garantire un bilanciamento attraverso la ridistribuzione e talvolta la limitazione delle libertà a protezione delle comunità.
La solidarietà intergenerazionale è riconosciuta come un principio fondamentale, presente in ogni società e in grado di favorire la coesione sociale, nonostante le complessità del garantire diritti alle generazioni future, date le difficoltà di attribuire soggettività a chi non è ancora nato.
Il cambiamento di paradigma è da ricercare quindi nello spostamento del focus dai diritti individuali al binomio solidarietà/responsabilità. Questo approccio supera l’apparente separazione tra generazioni presenti e future, vedendo entrambe come parte della stessa specie. La solidarietà verso il futuro, infatti, non riguarda solo il mantenimento di standard di vita, ma la conservazione della specie umana stessa, garantendo così anche il benessere delle generazioni attuali.

La responsabilità intergenerazionale nel diritto
Numerose normative già incorporano principi di responsabilità verso le generazioni future, soprattutto nel campo della tutela ambientale. A livello internazionale, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) richiama esplicitamente la necessità di salvaguardare i diritti delle generazioni successive attraverso azioni volte a contrastare il riscaldamento globale.
A livello nazionale, diverse costituzioni integrano riferimenti alla sostenibilità e alla protezione ambientale. Questi principi orientano le politiche pubbliche verso un uso responsabile delle risorse e promuovono una visione a lungo termine che consideri l’impatto delle scelte presenti sul futuro.
Alcuni casi di giurisprudenza innovativa li ritroviamo quindi ad esempio in una sentenza tedesca del 2021, che ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni della legge climatica per non aver distribuito adeguatamente gli oneri di riduzione delle emissioni tra generazioni. In Colombia, una decisione simile ha imposto alle autorità azioni concrete per fermare la deforestazione, evidenziando il legame tra ambiente e diritti fondamentali.
Ancora, il fondo generazionale del Quebec, che riserva risorse economiche per alleviare il debito pubblico futuro, dimostrando che responsabilità intergenerazionale e benefici futuri possono tradursi in norme vincolanti. Questi strumenti rappresentano un tentativo di riconoscere, anche giuridicamente, la connessione tra presente e futuro, promuovendo un approccio più sostenibile e solidale.
Superare l’alterità tra generazioni
Un approccio basato sul concetto di specie consente di superare la separazione percepita tra le generazioni attuali e quelle future. In questa prospettiva, le generazioni successive non sono viste come entità distinte, ma come una continuazione della comunità umana. Questo approccio permette di interpretare la solidarietà intergenerazionale come un legame naturale, intrinseco a qualsiasi società, e non come un obbligo imposto dall’esterno.
Garantire condizioni favorevoli per le generazioni future diventa, in questo modo, una forma di autoconservazione per le generazioni presenti. Le azioni che preservano l’ambiente, le risorse e le strutture sociali non solo favoriscono il benessere futuro, ma migliorano anche la qualità della vita nel presente, creando un circolo virtuoso.
La solidarietà intergenerazionale rappresenta un elemento cardine per affrontare le sfide globali del nostro tempo. Considerare l’umanità come una comunità unica e transgenerazionale offre una base teorica e pratica per orientare le politiche pubbliche e le decisioni individuali verso obiettivi condivisi. Integrare i diritti delle generazioni future nei sistemi giuridici e nelle scelte politiche richiede un cambio di prospettiva, che vada oltre l’individualismo e abbracci una visione più ampia della responsabilità collettiva. Questo approccio non solo garantisce la continuità della specie, ma contribuisce anche a creare una società più equa, sostenibile e inclusiva.
Riferimenti
https://turia.uv.es/index.php/cuadernosconstitucionales/article/view/28022