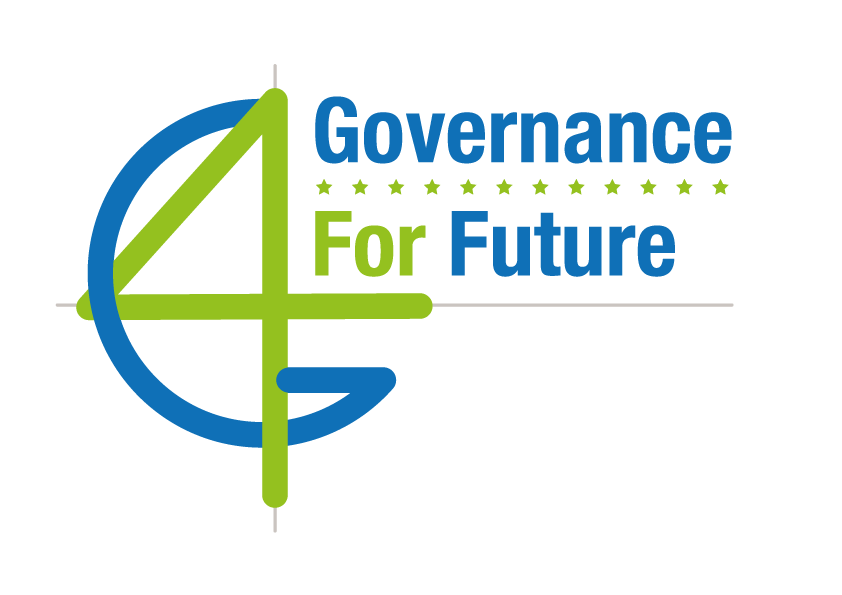Il contributo dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro
Il principio di parità salariale
Il concetto di uguaglianza di remunerazione per un lavoro di egual valore è un principio contenuto nella Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (nota come OIL) e risale al lontano 1919. Tale principio fondamentale stabiliva che, indipendentemente dalle caratteristiche personali di chi svolge un lavoro, il criterio fondamentale per determinare il salario risiede nel valore del lavoro svolto.
Questo principio generale, già internazionalmente riconosciuto, viene recepito nel 1951 nella Convenzione OIL n. 100 sulla parità salariale tra uomo e donna: questa convenzione sancisce l’obbligo degli Stati di garantire l’applicazione del principio di parità di trattamento retributivo attraverso la valutazione del valore del lavoro, a prescindere dal fatto che la prestazione sia svolta da una lavoratrice o un lavoratore. All’epoca dell’adozione, questo divieto di discriminazione e gli altri principi sanciti dalla Convenzione venivano considerati all’avanguardia in un contesto nel quale le donne continuavano ad essere considerate come lavoratrici secondarie.
Questo principio è riconosciuto anche dall’articolo 36 della Carta costituzionale italiana, ma la sua attuazione è stata più volte rimandata creando inevitabilmente scontri e dibattiti, che videro protagoniste le donne all’interno di più forze politiche e sindacali, del movimento operaio e dell’associazionismo femminile.
Uno sguardo alla storia
Le lavoratrici italiane combattevano per il diritto di parità salariale fin dal XIX secolo, quando, per via del minor costo del loro lavoro rispetto a quello maschile, migliaia di loro entrarono nelle fabbriche italiane durante la prima fase di industrializzazione.
L’introduzione della Convenzione OIL n. 100 dette una forte spinta agli attori politici ed economici italiani per affrontare il problema della parità salariale in modo più incisivo: il dibattito e la mobilitazione si svilupparono non nell’ambito delle organizzazioni politico-sindacali di sinistra ma anche all’interno delle istituzioni di Governo, dell’intero movimento operaio e tra le donne cattoliche.
Gli studi che hanno affrontato il tema della parità salariale nel contesto italiano hanno privilegiato il ruolo delle organizzazioni sindacali, senza indagare le azioni importanti che altri attori hanno ricoperto tra gli anni Quaranta e Sessanta. Poca attenzione è stata riservata, ad esempio, alla discussione parlamentare e all’iter legislativo seguito all’approvazione prima e alla ratifica poi della Convenzione OIL n. 100; allo stesso modo, il ruolo cruciale delle associazioni femminili è rimasto sullo sfondo.
Alcune leader femminili come Teresa Noce e Marisa Rodano, sono state figure centrali nella battaglia per la parità salariale, giocando un ruolo strategico durante la guerra e nel secondo dopoguerra: esse erano attive in diversi ambiti, impegnate come sindacaliste e parlamentari, o come parlamentari e leader di associazioni femminili quali l’Unione Donne Italiane (UDI).
Fu proprio grazie alla varietà dei ruoli ricoperti da queste donne (politico, sindacale e di leadership) che le rivendicazioni femminili ebbero particolare risonanza nella discussione politica nazionale.
Il ruolo dei sindacati
Come affermato da varie sindacaliste, la parità salariale era affrontata in maniera superficiale e retorica nella strategia della CGIL fino alla seconda metà degli anni Cinquanta: infatti, almeno fino al 1955, il principale sindacato italiano promosse la riduzione dei differenziali salariali tra donne e uomini, anziché promuovere il principio della parità salariale tout court.
Nel dibattito pubblico italiano, la parità di stipendio era strettamente connessa al diritto al lavoro per donne e uomini. Tuttavia, nonostante il principio di parità tra uomo e donna e la parità salariale fossero entrati nel testo costituzionale del 1948 (infatti l’articolo 37 recita «La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore»), il principio generale di parità e uguaglianza di trattamento tra donne e uomini proposto dalle parlamentari italiane, dovette cedere il passo all’idea egemonica più limitata della adeguata protezione della lavoratrice madre. L’articolo 37, infatti recita così: «Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione».
Di conseguenza, l’unica forma di lavoro femminile tutelata era quello delle donne con famiglia e i contratti di lavoro sia nel settore privato che in quello pubblico riproponevano uno schema generale di retribuzioni e qualifiche basate sul sesso, in virtù del quale le donne venivano pagate meno dei colleghi maschi.
Fino alla ratifica della Convenzione OIL del 1951, l’articolo 37 è stato il principale riferimento legislativo per la promozione del diritto di parità.
L’influenza della Convenzione OIL
Nell’Italia dei primi anni Cinquanta, la Convenzione OIL influenzò le proposte di legge che miravano ad affermare la parità salariale per via legislativa: dopo il 1951 tutti i progetti di legge presentati fecero esplicito riferimento alla stessa. Il primo progetto di legge sulla parità salariale annunciato al Parlamento italiano risale al 1952 e vide Teresa Noce quale prima firmataria. Oltre a lei figuravano altre 11 parlamentari donne, appartenenti sia al Partito comunista che a quello socialista, e più di 20 parlamentari uomini.
Nel solo 1952, le lavoratrici industriali inviarono centinaia di petizioni al Senato per supportare la proposta di legge della Noce.
Marisa Rodano e la Conferenza del 1957
La cosiddetta Conferenza del 1957 determinò un punto di svolta sia nel dibattito politico sulla parità salariale che nell’azione femminile per dare attuazione a questo principio. Per tre giorni, i partecipanti analizzarono in profondità il valore normativo della Convenzione OIL n. 100 e il suo recepimento in un progetto di legge sulla parità salariale, volto a implementare la Convenzione OIL, contratti collettivi da ottenere con l’intermediazione del Ministero del Lavoro. Studiosi, sindacalisti, leader di associazioni femminili e altri rappresentanti dei lavoratori concordarono che ratificare la Convenzione n. 100 fosse cruciale, per portare avanti la battaglia delle donne per la parità salariale.
Marisa Rodano, in qualità di Presidente dell’UDI, una delle associazioni femministe che ebbe un ruolo chiave sia nell’organizzazione della Conferenza che nella battaglia per la parità salariale tra anni Quaranta e Cinquanta , propose ufficialmente di trasformare il Comitato organizzatore della conferenza in una struttura permanente.
Tale Comitato operò almeno fino alla metà degli anni Sessanta, promuovendo temi oggetto di discussione e mobilitazione come l’istruzione professionale della donna e i licenziamenti per matrimonio.
La lotta delle donne nel settore agricolo
Il dibattito politico e la lotta delle donne nel settore agricolo ebbero un differente percorso e cronologia, influenzato direttamente dall’esodo dalle campagne negli anni Cinquanta e Sessanta.
Dall’immediato secondo dopoguerra, le donne contadine si organizzarono in una organizzazione affiliata all’UDI — le «Donne della Campagna» — che raccoglieva tutte le lavoratrici donne del settore agricolo. Le organizzazioni sindacali dell’agricoltura crearono sezioni femminili, come avvenne all’interno della Federmezzadri e Federbraccianti della CGIL. Anche in questo settore la giusta valutazione del lavoro delle donne era un obiettivo cruciale per ottenere la parità di remunerazione, dal momento che, alla fine degli anni Cinquanta, il lavoro agricolo femminile era ancora valutato al 40% in meno di quello maschile. L’UDI, con le ACLI, giocarono un ruolo cruciale nel promuovere le rivendicazioni delle donne contadine per la parità di remunerazione.
L’UDI promosse una proposta di legge di iniziativa popolare sulla parità salariale in agricoltura, accolta nel 1964. Raccolse le necessarie 50.000 firme, spedite simbolicamente alla fiera internazionale dell’agricoltura.
Il dibattito e le lotte sulla parità salariale non finirono nei primi anni Sessanta con queste leggi e accordi, ma portarono all’approvazione della legge n. 903 del 9 Dicembre 1977, che vieta qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro e indipendentemente dalle modalità di reclutamento.
Riferimenti
Le alleanze delle donne italiane per la parità salariale
Per la scuola L’alleanza delle donne per la parità salariale