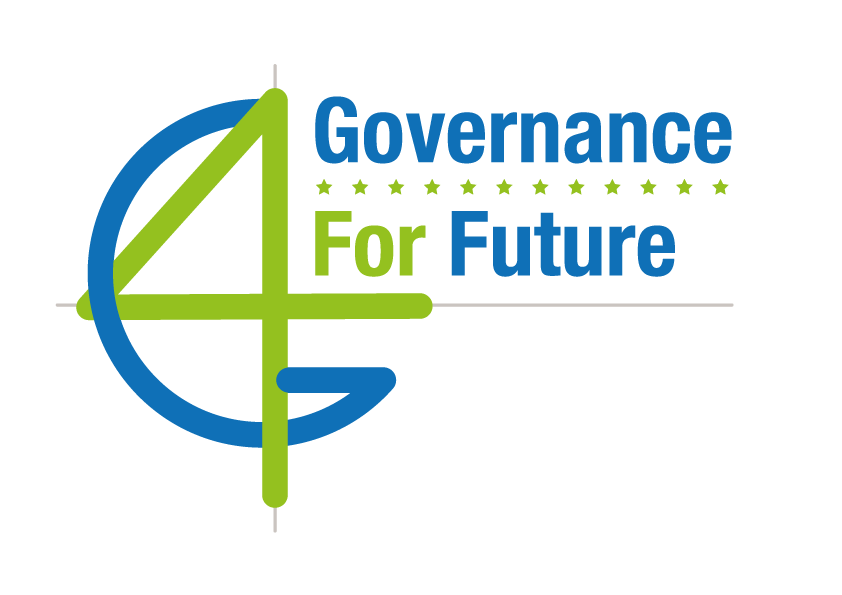Capacity-building e strumenti finanziari
Una delle tendenze più recenti dell’Unione Europea è quella di promuovere nuove forme di governance basandosi su un sistema di incentivi, con l’obiettivo di aiutare i paesi ad agire strategicamente nelle priorità comuni, come nel caso dell’efficienza energetica, dell’energia rinnovabile e del trasporto urbano sostenibile. Tuttavia, gli strumenti di capacity-building messi a disposizione per aumentare le capacità amministrative e istituzionali dei singoli governi non sempre funzionano bene come dovrebbero, in particolare quando sono di tipo finanziario.
Quali sono le ragioni di questo malfunzionamento? E in che modo lo stato di avanzamento dei paesi beneficiari influisce sulla buona riuscita dei programmi? Si vedrà come la disponibilità di risorse di base di partenza e la loro capacità di attingere ai fondi dell’UE emergono come fattori chiave.
Il programma ELENA (European Local ENergy Assistance)
Un caso di ricerca sulla validità dei programmi di capacity-building è costituito dall’efficacia di ELENA, un’iniziativa congiunta lanciata dalla Commissione Europea e dalla BEI (Banca Europea per gli Investimenti) nel 2009 come primo strumento di assistenza tecnica per il potenziamento delle capacità di sviluppo e gestione dei progetti delle autorità locali nel campo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica. Attraverso ELENA, tra il 2009 e il 2019 l’Unione Europea ha finanziato 100 progetti con una spesa totale di oltre 130 milioni di euro, chiedendo ai beneficiari di stabilire accordi organizzativi e finanziari innovativi per l’azione sul clima e innescando un investimento stimato di circa 5 miliardi di euro.
Appare evidente come la maggior parte dei beneficiari del programma ELENA provenga da vecchi Stati membri dell’UE. L’Italia ha registrato il maggior numero di progetti (12), seguita da Danimarca e Paesi Bassi (con 11 progetti ciascuno) e dal Regno Unito (10 progetti), Spagna (7), Belgio (6), Francia (6) e Polonia (6). I progetti provenienti da questo gruppo di otto paesi rappresentano quasi il 70% di tutti i progetti finanziati dal programma. Ad eccezione della Germania, che ne conta 4, gli altri paesi sono in ritardo.
Il 30% dei progetti finanziati sono stati presentati da comuni, seguiti da aziende di proprietà del governo locale (18%), agenzie per l’energia locale (12%), governi regionali (11%), province (10%) e società private (10%); il rimanente 9% è costituito da ministeri nazionali, università, fondazioni. Infine, il 47% riguarda il settore dell’energia (energie rinnovabili ed efficienza energetica), edifici residenziali (25%), illuminazione stradale (10%), trasporti (8%), riscaldamento (6%), altri edifici residenziali (3%).
E i contesti sfavoriti?
L’analisi dei dati evidenzia come un numero considerevole di progetti provenga da paesi che non dispongono di politiche climatiche consolidate e di strumenti politici specifici. Ciò vale in particolare per l’Italia, che ha registrato il maggior numero di beneficiari e, in certa misura, per la Spagna. In entrambi i paesi, i governi non solo hanno dovuto affrontare un quadro politico sfavorevole, ma hanno anche sperimentato significativi vincoli di bilancio a seguito della crisi economica del 2008. Pertanto, percepiscono i programmi di finanziamento dell’UE come la più importante fonte di sostegno finanziario per rafforzare la loro azione sul clima.
Va tuttavia segnalata una divergenza significativa anche tra i paesi dell’Europa centrale e orientale. Diversi paesi di questa regione (come ad esempio Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria) mostrano un quadro di politica climatica ancora poco sviluppato e una scarsa partecipazione al programma ELENA.
Dalle interviste è inoltre emerso come lo sviluppo di progetti da presentare alla BEI sia stato un processo impegnativo, che ha richiesto conoscenze specifiche, personale ed esperienza, non sempre disponibili a livello locale. Questi risultati suggeriscono che i programmi di rafforzamento delle capacità come ELENA potrebbero mancare i loro obiettivi ogniqualvolta i potenziali beneficiari non dispongano della capacità minima necessaria per raggiungere la soglia di ammissibilità richiesta per ottenere finanziamenti comunitari.
Strumenti di governance multilivello
Come hanno dimostrato recenti studi sulla governance climatica dell’UE, il coinvolgimento degli attori regionali e locali è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi europei secondo la situazione specifica e i bisogni dei singoli Stati membri. Maggiore è la coesione e la sovrapposizione degli strumenti politici (per questo si parla di govenance multilivello), più crescono le opportunità per migliorare le rispettive capacità nel campo dell’energia e del clima sostenibili. La partecipazione delle piccole città e dei comuni al programma ELENA, al di là delle iniziative della Commissione, è stata facilitata dalla creazione di reti informali coordinate dai paesi beneficiari.
Nello specifico, tra i 35 comuni che hanno utilizzato il programma ELENA per attuare 40 progetti (compresi i progetti promossi da società municipali), 23 erano città che partecipano ad almeno un TMN (Transnational Municipal Network): più le città sono impegnate con queste reti, più sono attrezzate in termini di esperienza, risorse e conoscenze necessarie.
Anche la partecipazione all’iniziativa CoM (EU Covenant of Mayors) è stata essenziale per fornire agli attori locali le conoscenze specifiche di esperti e il sostegno relazionale necessari per soddisfare i criteri stabiliti dalla BEI per accedere ai finanziamenti ELENA e per colmare il divario di capacità iniziale che avrebbe ostacolato la partecipazione delle città più piccole e dei “ritardatari climatici” al programma.
In Italia, un caso virtuoso è quello del progetto G.R.O.W.S (Green Revolution Of Wealth in Salento) presentato da Campi Salentina (LE), il comune più piccolo tra i beneficiari del programma. L’ambizioso progetto, sottoscritto da 27 partner locali, punta a riqualificare molti edifici situati all’interno dei comuni interessati e illuminare le città, diminuendo l’impatto ambientale e garantendo così la massima efficienza energetica e un risparmio per l’ambiente e per la società.
Aggirare i limiti facendo rete
Nonostante il dibattito sul rafforzamento delle capacità nell’UE, ci sono stati pochi sforzi per valutare l’efficacia degli strumenti di capacità d’azione e le loro traiettorie di attuazione; esistono prove del fatto che i programmi possono produrre risultati diversi, in termini di sviluppo di capacità, a seconda dei particolari contesti nazionali e delle condizioni di partenza. In altre parole, quando si mettono a disposizione finanziamenti spesso si favorisce chi è già forte e possiede capacità progettuale, mentre i paesi svantaggiati in termini organizzativi restano indietro.
Per ovviare agli attuali limiti degli strumenti di capacity-building, che hanno come leva esclusiva quella finanziaria, è indispensabile fare rete e fornire ai comuni delle alternative adeguate e funzionali: offrire formazione, sviluppare nuove skills di progettazione, aggiornare i soggetti più “deboli” sugli strumenti partecipativi già in essere (quali i già citati CoM e TMN) per renderli più competitivi sul campo internazionale.
Riferimenti
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcms.13199
Materiali per scuola
Stampa e discuti in classe: L’azione locale per il clima nell’Unione Europea