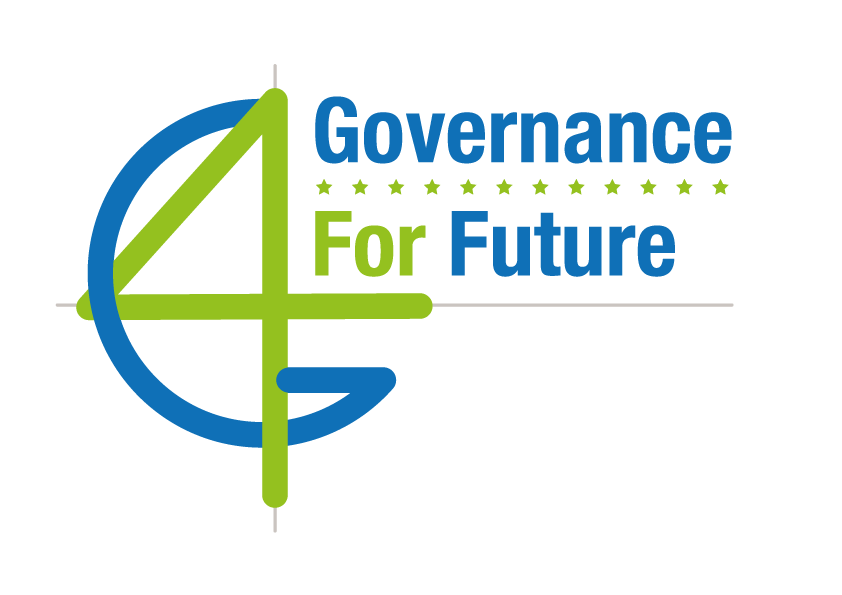Violenza di genere e diritti umani
Nel 2018, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha dichiarato come la violenza di genere sia il tratto più allarmante che accomuna le donne straniere nelle rotte migratorie verso l’Europa. Gravi episodi di subordinazione e sottomissione, nonché di violenza sessuale, fanno da sfondo agli esodi delle donne, il cui rischio maggiore è di rimanere intrappolate nel meccanismo della tratta di esseri umani o in reti criminali, con la conseguente privazione dei loro diritti. La condizione di vulnerabilità che affligge le migranti si basa infatti su fattori come il sesso, la nazionalità, l’età, l’indebitamento e il background culturale. Una volta raggiunta la destinazione, i meccanismi di protezione messi in atto dai paesi europei per evitare tali violazioni non sono sufficientemente strutturati per affrontare il fenomeno con un approccio intersezionale (ovvero tenendo conto dell’esperienza diretta delle vittime). Infatti, se da un lato il fenomeno della violenza maschile contro le donne è emerso di recente con una grande visibilità, l’impegno istituzionale da parte delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa per la promozione e la protezione dei diritti umani delle donne si è concentrato principalmente sulla violenza da parte dei partner intimi. Si è però ancora lontani dal riconoscere l’interazione tra violenza di genere, vulnerabilità e sfruttamento delle donne in relazione alla migrazione internazionale. Come possono essere protetti i diritti umani delle donne? E come affrontare adeguatamente le esigenze delle donne migranti nei meccanismi di protezione italiani?
Le ragioni degli esodi
In paesi europei come l’Italia, la migrazione femminile è ancora percepita come una dinamica passiva, secondo la quale alla donna non viene concessa possibilità di scelta e il trasferimento all’estero è strettamente correlato alle esigenze famigliari (la donna emigra per prendersi cura del marito, dei figli, ecc.). Questo presupposto, assai fuorviante, non prende in considerazione come migliaia di donne in questi ultimi decenni si siano trasferite all’estero da sole per sostenere la famiglia, per conquistare una piena autonomia e migliorare la loro condizione personale. Le ragazze adolescenti spesso fuggono da un matrimonio forzato o precoce, dalla mutilazione genitale o da altre pratiche invasive; in paesi come la Nigeria, la discriminazione nei confronti delle giovani donne è il principale fattore di spinta alla migrazione. Diversi rapporti pubblicati da organizzazioni internazionali confermano la condizione di fragilità delle donne, soprattutto di quelle che viaggiano senza famiglia o con bambini piccoli e che allattano.
Uno sguardo all’Italia
Negli anni più recenti, in Italia il tema della violenza di genere contro le donne immigrate è stato oscurato dal dibattito politico repressivo nei confronti dei migranti. Tali scelte politiche hanno agevolato l’occultamento di gravi fatti di violenza che vedono vittime le donne richiedenti asilo; le realtà più frequenti sono gli abusi sessuali da parte dei datori di lavoro, in particolare nel contesto dei servizi domestici e di assistenza. Gli episodi di violenza che si consumano all’interno delle mura domestiche sfuggono a ogni controllo legale, nonché alle cronache televisive. Inoltre, il nostro Paese non ha ancora applicato un piano di protezione globale basato sull’intersezione delle diverse vulnerabilità della donna, e i sistemi anti-traffico e anti-violenza funzionano separatamente. Esistono però reti di donne, professionisti, volontari, attori e parti interessate che contribuiscono a sostenere gli sforzi realizzati dai centri anti-violenza al fine di assistere, aiutare e proteggere le vittime femminili nei diversi territori. La necessità di integrare questi sistemi favorendo un reale scambio in termini di competenze e pratiche costituirebbe un grande miglioramento per garantire un approccio più ampio sia alle forme di sfruttamento sessuale che ad altre forme di violenza maschile. Significherebbe agire per ottenere titoli di residenza in grado di riconoscere la complessità delle violazioni dei diritti umani delle donne.
La legislazione italiana in materia di asilo
Dopo l’aumento dei flussi migratori nel 2015, il sistema italiano di lotta alla tratta di esseri umani e le commissioni territoriali di asilo hanno cominciato a collaborare; al 2016 risalgono le linee guida del Ministero degli Interni per le commissioni d’asilo – le quali forniscono segnali specifici per l’osservazione dei casi in cui il richiedente asilo sia una donna nigeriana e quindi una potenziale vittima di tratta e sfruttamento. Gli stereotipi culturali e il sospetto di un uso strumentale degli strumenti legislativi da parte delle donne straniere costituisce un ostacolo alla loro sicurezza, così come la scarsa diffusione di informazioni sulla possibilità di accedere ai permesso di soggiorno, sia tra le forze dell’ordine che tra le donne vittime di violenza.
Gli articoli 18 e 18-bis
L’articolo 18 della legge 286/1998 prevede la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per la protezione sociale per i cittadini di paesi terzi che, arrivati in Italia, vivono una situazione di violenza o di grave sfruttamento, anche come conseguenza di essere testimoni cooperanti contro i loro sfruttatori. La legge promuove un meccanismo atto a prevenire e sopprimere le situazioni criminali attraverso la costruzione di relazioni affidabili tra le vittime e i professionisti che lavorano nella rete di assistenza. Tuttavia, non dà sufficiente risalto ad altre tipologie di violenza di genere, come le pratiche di mutilazioni genitali femminili.
La Legge 119/2013 all’articolo 18-bis del D.Lgs. 286/9814 (la trasposizione dell’art. 59 della Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa del 2014) ha introdotto una nuova forma di autorizzazione di soggiorno. A tutti i cittadini di paesi terzi che, durante le indagini per reati specifici, sono stati trovati vittime di violenza domestica o abuso (e che si trovano in una situazione di pericolo reale) può essere concesso un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie della durata di un anno, periodo vincolante per la protezione sociale e l’assistenza, ma anche per l’accesso ai servizi di istruzione a contratti di lavoro. Inoltre, a differenza della Convenzione di Istanbul, il 18-bis non considera i casi in cui esiste un rischio di violenza nei paesi di origine (e nelle famiglie di origine) determinando così una situazione di vulnerabilità in caso di rimpatrio.
Sfide per il futuro
I professionisti e gli operatori nel campo del traffico umano e internazionale spesso non riconoscono la severità della violenza di genere nel favorire lo sfruttamento, riproducendo così dinamiche e forme di sottomissione; in tal senso occorre superare l’approccio di emergenza per lavorare su risposte più strutturate e consolidate, come l’ adozione di progetti intersezionali incentrati sul lavoro con le donne che hanno sperimentato la violenza, tenendo conto dei bisogni che ognuna di loro può esprimere.
Riferimenti
https://iris.unitn.it/handle/11572/264649
Materiali per scuola
Stampa e discuti in classe: Migrazione internazionale e violenza di genere