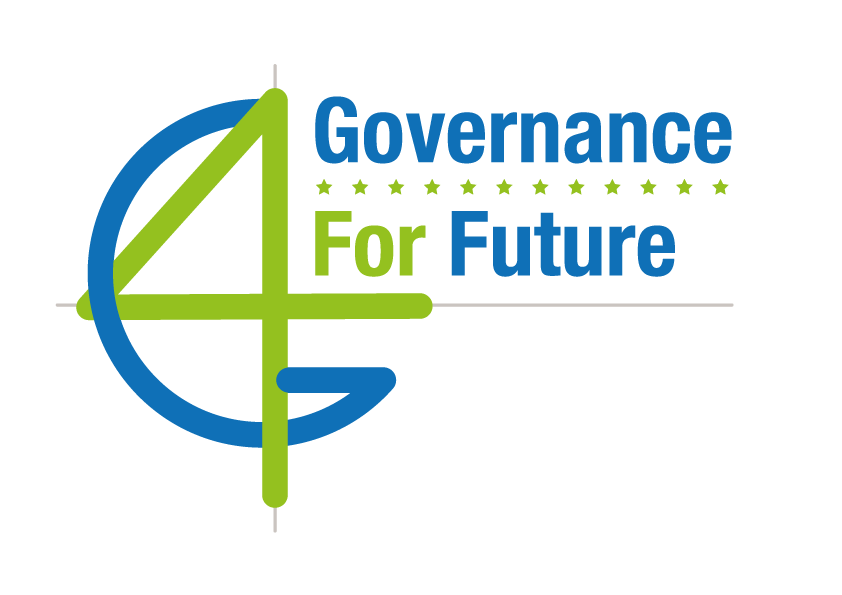Cosa vuol dire fallimento e cos’è il fallimento delle politiche migratorie
Dal 24 febbraio 2022, in seguito allo scoppio del conflitto in Ucraina, migliaia di ucraini hanno cercato rifugio in Europa. L’Italia è stata una delle principali destinazioni anche in virtù della presenza di una numerosa comunità ucraina. Un afflusso di tale portata e in così poco tempo ha reso necessario predisporre in tempi rapidi misure di accoglienza su vasta scala. La cittadinanza ha prontamente risposto anche con grande spirito di solidarietà, tuttavia, nonostante il consenso politico e il sostegno popolare, i risultati delle politiche pubbliche sono stati fallimentari. Solo una parte dei rifugiati ha beneficiato delle misure previste, e ci sono stati ritardi e inefficienze nell’assistenza, causando uno spreco di risorse economiche e umane.
Per comprendere cosa ha portato a queste problematiche è importante partire dal concetto di fallimento e quindi contestualizzare il fenomeno all’interno della gestione delle politiche migratorie.
Secondo l’enciclopedia Treccani, il fallimento è definito come “insuccesso, flop, scacco”, una “situazione, sforzo non andato a buon fine”. In altre parole, si verifica un fallimento quando c’è una differenza, uno scollamento tra gli obiettivi che ci si prefigge e gli effettivi risultati, la mancata realizzazione di un obiettivo o di un risultato atteso.
In questo caso specifico è legato in particolare alle politiche migratorie, ovvero tutte quelle azioni introdotte dai governi per organizzare e gestire al meglio gli ingressi più o meno a lungo termine di persone nel proprio territorio. A tal proposito, nonostante gli Stati europei avessero dichiarato politiche di “immigrazione zero” tra gli anni ’70 e 2000, l’immigrazione è proseguita per vari motivi, dai ricongiungimenti familiari alle richieste di asilo o ancora, per motivi lavorativi, per i quali gli Stati hanno adottato misure più flessibili per gli ingressi.
Le cause che possono portare a un fallimento di queste politiche possono essere molteplici e dipendono da diverse variabili, come fallimenti che includono un intero regime politico o programmi specifici, fallimenti di lunga durata o circoscritti nel tempo. Ancora, influiscono sulle cause quanto il fallimento sia diventato di dominio pubblico o quanto si è riusciti a contenere la diffusione della notizia nella popolazione e di conseguenza come reagisce la cittadinanza a livello di consenso. Altri fattori importanti sono relativi al momento in cui si verifica un fallimento politico, ovvero se avviene durante la formulazione o l’attuazione, se la pianificazione di un’agenda politica si rivela irraggiungibile, se un processo decisionale non riesce a decidere su una politica entro un tempo ragionevole, oppure si attua una valutazione che non riesce a produrre feedback efficaci a causa di monitoraggi inadeguati.
La combinazione di queste cause porta quindi al fallimento della governance, che diviene quindi il risultato di mancate corrispondenze tra le politiche messe in atto e la natura del problema, o quando le politiche sono corrette ma competenze e capacità del governo sono inadeguate. Un ulteriore fattore da tenere in considerazione è la governance multilivello, quindi l’interazione che coinvolge, oltre che attori statali e non statali, le interazioni e i (tentativi di) coordinamento tra i diversi livelli di governo e tra i diversi attori della sfera pubblica.

Fonte: Pexels
Il caso dei rifugiati ucraini in Italia
Il caso italiano dei rifugiati ucraini si presta particolarmente per comprendere le dinamiche del fallimento delle politiche migratorie. L’Italia ha affrontato negli ultimi quindici anni un notevole afflusso di rifugiati, con la conseguenza di un sistema di governance nelle politiche di accoglienza messo a lungo alla prova. Questo contesto, caratterizzato da una non politicizzazione e da un sostegno diffuso ai rifugiati ucraini, fornisce un ambiente ideale per esplorare come e perché le politiche possono fallire, anche in condizioni apparentemente favorevoli.
Dopo una serie di provocazioni iniziate con la Rivoluzione di Euromaidan nel 2014 (e la conseguente occupazione russa della Crimea) e proseguite nei mesi precedenti l’invasione con l’accerchiamento dell’Ucraina con le proprie truppe nel 2021 e l’autoproclamazione delle repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, nella notte del 24 febbraio 2022 l’esercito russo di Vladimir Putin ha invaso l’Ucraina.
Una delle immediate conseguenze dello scoppio del conflitto sono stati gli oltre 7 milioni di sfollati, con molti rifugiati diretti verso l’Europa. L’Italia, grazie alla presenza di una numerosa comunità ucraina, è stata una delle principali destinazioni. Tra febbraio e maggio 2022 infatti, oltre 100.000 ucraini hanno cercato rifugio nel nostro Paese. Questo grande afflusso ha richiesto interventi rapidi e soluzioni abitative di emergenza, oltre a una pianificazione più strutturata per l’accoglienza a medio termine. La società civile e la politica italiana hanno risposto in modo generoso, con numerose iniziative di accoglienza in diverse forme: sia donazioni in denaro, sia misure di inclusione sociale, ma anche di ospitalità presso abitazioni private.
In particolare, molti connazionali già residenti in Italia hanno ospitato una buona parte di questi rifugiati, mentre altri sono stati accolti da famiglie italiane con legami personali o familiari. Diverse associazioni di volontariato, cittadini, parrocchie e enti del terzo settore (ETS) si sono mobilitate spesso prima delle istituzioni pubbliche, offrendo alloggio e sostegno sociale modo informale, senza supporto economico o organizzativo da parte delle autorità. Questa risposta spontanea, benché generosa, ha creato confusione e difficoltà nella gestione delle offerte.
Cosa è andato storto?
Le fasi principali nella costruzione del sistema di governance per l’accoglienza dei rifugiati ucraini, messe in atto dal Consiglio dei Ministri sono state:
- Dichiarazione dello stato di emergenza con assegnazione del coordinamento alla Protezione Civile (delibera del 28 febbraio 2022).
- Sviluppo di un sistema di coordinamento regionale (Ordinanza OCDPC n. 872/2022).
- Ampliamento del sistema di accoglienza: Il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) e i Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) sono stati ampliati (DL n. 16 del 28 febbraio 2022; DL n. 115 del 9 agosto 2022; Decreto del Ministro dell’Interno del 23 agosto 2022).
- Contributo economico per soluzioni abitative autonome di 300 euro al mese per un massimo di tre mesi ai rifugiati ucraini che hanno trovato da soli una soluzione abitativa, fuori dal sistema di accoglienza formale (OCDPC n. 881/2022).
- Avvio dell’accoglienza diffusa, comprendente l’ospitalità presso famiglie e l’alloggio autonomo in appartamenti privati, gestito tramite ETS, (DL n. 21 del 21 marzo 2022; OCDPC n. 881/2022).
Dopo l’annuncio del finanziamento per 15.000 alloggi temporanei da parte della Protezione Civile e l’approvazione di 29 proposte da parte di consorzi di organizzazioni del terzo settore, una serie di problemi burocratici e organizzativi hanno rallentato l’attuazione di queste misure. La richiesta di una documentazione complessa da parte della Protezione Civile è stata la causa di un primo rallentamento, al quale si è aggiunta una maggior centralità per i comuni, richiesta dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), che ha comportato la stipula di accordi di partenariato con ogni Comune coinvolto. Le elezioni amministrative di giugno 2022 hanno ulteriormente complicato e ritardato il processo.
Nonostante gli sforzi iniziali e le risorse mobilitate, al 4 agosto 2022 solo una parte degli accordi era stata formalizzata, con molte potenziali famiglie ospitanti non disponibili a causa delle vacanze estive. Alla fine di dicembre 2022, erano state attivate solo 14 delle 29 convenzioni previste, ma solo poche centinaia di rifugiati erano stati effettivamente accolti. Questo ritardo ha costretto molti rifugiati, inizialmente alloggiati temporaneamente in alberghi, a rimanere in tali strutture per periodi molto più lunghi del previsto, evidenziando le difficoltà e i fallimenti nel passaggio dalla pianificazione all’implementazione effettiva del sistema di accoglienza.

Fonte: Pexels
Le cause del fallimento
Una prima causa del fallimento particolarmente evidente è l’eccessiva burocrazia, che ha rallentato il flusso di lavoro delle ETS con troppi documenti richiesti in una situazione di emergenza. Questo ha causato ritardi a catena, concentrando gli sforzi solo nei grandi comuni e lasciando fuori molti piccoli centri. Sono emersi quindi altri vincoli che hanno complicato le procedure, come la richiesta arbitraria di documenti aggiuntivi, provocando ulteriori rallentamenti al processo.
L‘obiettivo del programma era chiaro ma mal concepito, poiché non era ben definito chi fossero i beneficiari e quali libertà avessero. Le ETS volevano dare priorità ai rifugiati già ospitati, ma la Protezione Civile ha preferito trasferire chi era ospitato negli alberghi. Questo ha portato a obiettivi incompatibili, aggravando il processo di accoglienza.
Nonostante l’accordo generale sull’accoglienza degli ucraini, il processo politico ha sofferto di conflitti nascosti tra i vari attori, emersi solo in un secondo momento. Uno dei principali attriti si è rivelato essere la decisione del governo di affidare la gestione dell’accoglienza alla Protezione Civile invece che al Ministero dell’Interno, per motivi di praticità e accesso rapido a risorse economiche. La Protezione Civile infatti, richiamando l’esperienza dell'”Emergenza Nord Africa” del 2010-201″, ha creato un nuovo modello di accoglienza simile al SAI ma senza coinvolgere i Comuni. Questo ha causato malcontento all’ANCI, che temeva l’esclusione dei Comuni e ha fatto pressione per modificare il processo, allungando i tempi e creando ulteriori difficoltà per le organizzazioni del terzo settore.
Inoltre, l’attivazione della Protezione Civile a livello nazionale è stata lenta rispetto alla rapida risposta delle ETS e dei comuni, che hanno subìto forti pressioni fin dai primi giorni del conflitto. Le ETS avevano già iniziato ad accogliere rifugiati prima dell’intervento della Protezione Civile, assumendosi responsabilità importanti. Tuttavia, l’uso di strumenti amministrativi ordinari, invece di quelli straordinari, ha ulteriormente rallentato il processo, complicato anche dalle elezioni locali. Questo ha fatto sì che l’intervento richiedesse mesi, invece di una risposta rapida e adeguata all’emergenza.
Un ripensamento della governance multilivello
In sostanza, l’emergenza migratoria si è trasformata presto in un’emergenza gestionale e la causa principale di questo insuccesso si può individuare in una burocrazia eccessivamente farraginosa, pesante, dove le modalità richieste per intervenire in soccorso si sono rivelate un ostacolo difficile da superare. A questo, si aggiunge un obiettivo mal concepito a partire dalla fase di definizione dell’agenda politica, quando la gestione dell’accoglienza è stata affidata alla Protezione Civile, escludendo i comuni e provocando la reazione dell’ANCI, che a sua volta ha rallentato l’intero processo creando ulteriori e ritardi e un conflitto tra le istituzioni.
In secondo luogo quindi, proprio le dinamiche di governance multilivello (soprattutto nella fase di definizione dell’agenda) hanno contribuito in buona misura a questo esito. Il fallimento non scaturisce da conflitti ideologici o di partito, ma da attriti burocratici tra le istituzioni nazionali e una poca chiarezza su chi dovesse fare cosa e come a livello territoriale. L’efficacia del programma è stata minata da questi conflitti, dal sovrapporsi di troppi attori a più livelli che si sono mal coordinati anche a causa di direttive confuse.
Una soluzione al problema può derivare quindi proprio da un ripensamento della governance multilivello, con una particolare attenzione ai conflitti che si possono creare quando troppe parti entrano in gioco e non sono ben coordinate.
Riferimenti
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gove.12852
Stampa e discuti in classe
Stampa e discuti in classe: Perché può fallire una politica migratoria. il caso dei rifugiati ucraini in Italia
Per approfondire:
Origini e fasi del conflitto in Ucraina
Fine e fini dell’invasione in Ucraina