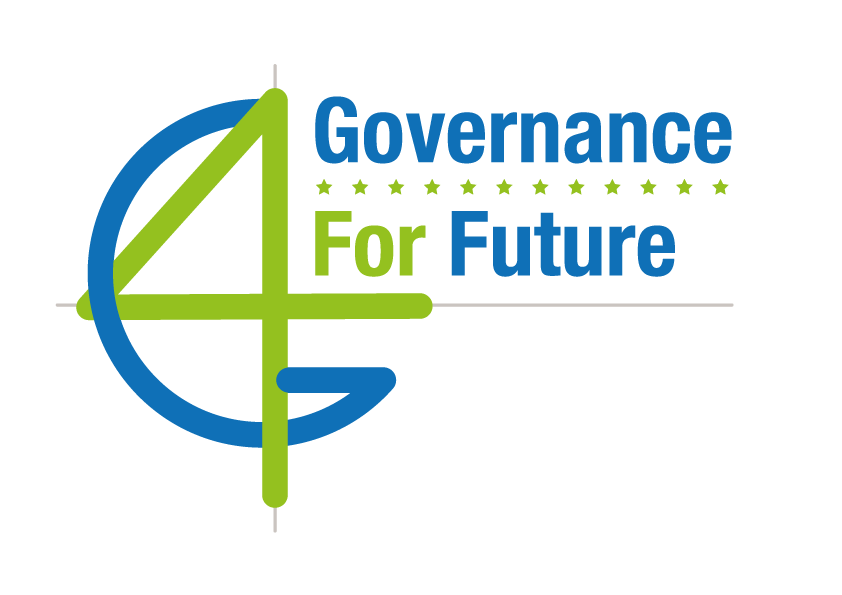Un megaprogetto può essere definito come un progetto di costruzione e investimento su grande scala, particolarmente complesso e con notevoli impatti anche a lungo termine su economia, ambiente e società. Può coinvolgere più regioni o nazioni, con conseguentemente la necessità di un coordinamento a più livelli. Lo sviluppo di megaprogetti è sempre più diffuso, e per far sì che si possano realizzare nei tempi e nelle modalità previste in fase di progettazione, gli studi si concentrano soprattutto su una gestione delle risorse che sia quanto più puntuale ed efficiente, all’interno di un quadro organizzativo ben definito.
Questo tipo di interventi però spesso si rivela particolarmente impattante nella vita dei cittadini attorno ai quali queste infrastrutture vengono costruite, portando anche a situazioni di conflitto. Per questo motivo, ultimamente è emersa la necessità di porre particolare attenzione alla governance partecipativa, ovvero a un maggior confronto con i cittadini che vengono coinvolti in modo diretto dai cambiamenti portati dai megaprogetti.
La governance partecipativa, coinvolgendo i cittadini nel processo decisionale, viene presentata dunque come una possibile soluzione per gestire la complessità e i conflitti che spesso generano questi grandi progetti. Un caso recente di megaprogetto in cui la governance partecipativa è stata applicata è quello della costruzione della ferrovia ad alta velocità Torino-Lione, che ha messo a confronto due modelli di gestione differente poiché il progetto ha interessato due Stati (Francia e Italia), con ognuno la propria legislazione, caratteristiche del territorio diverse, culture e approcci della popolazione diversi.

Fonte: Pexels
Il caso della ferrovia ad alta velocità Torino Lione
Il caso della ferrovia ad alta velocità Torino-Lione è un esempio di megaprogetto caratterizzato da complessità, incertezza e conflitti tra vari gruppi di interesse. L’idea di costruire una linea ferroviaria tra Lione e Torino risale al 1992, quando l’Unione Europea ha introdotto la Rete Transeuropea di Trasporto per migliorare la mobilità tra i paesi europei. Il piano prevedeva una linea di 270 km tra Lione e Torino, con un tunnel di 57 km che attraversa le Alpi tra la Valle di Susa (Italia) e la Maurienne (Francia). La costruzione del tunnel è stata affidata a una joint venture internazionale tra SNCF Réseau (Francia) e Rete Ferroviaria Italiana.
A distanza di quasi 30 anni il progetto è ancora incompleto, il costo è salito da 12 a 26 miliardi di euro e la data di completamento è stata posticipata al 2030. I ritardi principali sono dovuti all’opposizione dei gruppi civili della Valle di Susa, in Italia, dove è nato il movimento NO TAV, contrario alla costruzione per motivi ambientali, sociali ed economici. In Francia, invece, il processo è stato meno conflittuale. Mentre in Francia infatti la governance partecipativa ha seguito un processo ordinario e strutturato, legato a una legislazione preesistente e ben definita, in Italia è stata creata una soluzione straordinaria a posteriori a causa della forte opposizione sociale.

Fonte: Avvenire
Governance partecipativa in Francia: consultazioni pubbliche e sfide
In Francia il processo partecipativo per la ferrovia Torino-Lione si è svolto seguendo una procedura amministrativa ordinaria prevista dal sistema giuridico. Questa procedura obbligava la compagnia ferroviaria a organizzare consultazioni pubbliche con i cittadini e le organizzazioni civili interessate, supportate da un’autorità amministrativa composta da esperti indipendenti, incaricata di raccogliere le opinioni pubbliche e redigere un rapporto per il governo. Il progetto poteva poi ricevere la dichiarazione di pubblica utilità, un atto amministrativo che autorizzava la compagnia ferroviaria a procedere con l’acquisizione dei terreni necessari per la costruzione.
Durante le consultazioni, gli abitanti delle zone interessate hanno potuto esprimere i propri pareri in un registro comunale, che veniva poi esaminato da una commissione di inchiesta composta da ingegneri civili in pensione. Questo gruppo neutrale valutava la legittimità dei commenti e forniva una raccomandazione finale. In due mesi di incontri, rappresentanti del governo e tecnici hanno risposto alle domande dei cittadini, cercando di chiarire i dettagli, anche tecnici, del progetto.
Questa procedura di inchiesta pubblica ha permesso un confronto tra cittadini, società civile e le autorità, con l’obiettivo di informare la popolazione sugli aspetti tecnici del progetto ferroviario Torino-Lione e i cittadini avevano a loro volta l’opportunità di esprimere pareri e preoccupazioni.
Tuttavia, la procedura aveva un valore consultivo e non vincolante, lasciando la decisione finale al governo. Nonostante gli incontri, molti cittadini hanno trovato complessi i documenti tecnici e hanno percepito una mancanza di trasparenza, come osservato da alcuni sindaci che hanno criticato il processo per essere poco accessibile e potenzialmente manipolativo, nonché influenzato da decisioni già prese in precedenza.
Dagli anni ’90, alcune voci contrarie si sono levate contro la Torino-Lione. La trasparenza e il diritto di parola sono stati garantiti dal comitato incaricato degli incontri pubblici, ma critiche sono giunte da parte di esperti esterni. Nel 2002 e poi nel 2012, rapporti indipendenti rispettivamente dell’autorità francese di ingegneria civile e della Corte dei Conti Francese hanno messo in discussione la validità del progetto, contribuendo a rafforzare il movimento contrario, guidato da personalità come Daniel Ibanez. I detrattori sostenevano che le previsioni sul traffico merci fossero gonfiate, ma il Consiglio di Stato francese ha respinto le richieste di blocco del progetto nel 2017, dichiarando che le variazioni non rappresentavano un cambiamento significativo.
La gestione italiana: il ruolo dell’Osservatorio e le proteste della Val di Susa
In Italia, l’opposizione al progetto ha assunto una forte dimensione popolare, suscitando un forte dissenso locale sin dall’inizio, particolarmente in Val di Susa. La “Legge Obiettivo” istituita nel 2001, che centralizzava le decisioni sulle grandi opere nelle mani del governo, non prevedeva un obbligo di consultazione dei cittadini. Questo ha alimentato le tensioni e l’emergere del movimento NoTAV, che vedeva la Torino-Lione come un’opera imposta e inutile. La popolazione locale ha spesso contrastato l’apertura dei cantieri, portando a scontri con le forze dell’ordine e dando vita a un movimento determinato e radicato contro l’espropriazione delle terre e l’avanzamento del progetto. La tensione nella cittadinanza ha portato ai fatti di Venaus del 2005, quando i manifestanti NoTAV occuparono un cantiere per bloccare i lavori e furono successivamente sgomberati con forza dalla polizia.
In risposta, il governo italiano ha istituito l’Osservatorio Torino-Lione nel 2006, una sede di confronto straordinaria per dialogare con le amministrazioni locali e i gruppi contrari al progetto, cercando di ridurre il conflitto.
In Francia e in Italia, le modalità di opposizione al progetto sono state differenti: in Francia, l’opposizione è riuscita a trovare spazio nelle istituzioni, mentre in Italia ha assunto la forma di una mobilitazione popolare e di protesta extra-istituzionale. Il progetto Torino-Lione ha sollevato critiche in entrambi i Paesi, con oppositori come Daniel Ibanez che, durante l’inchiesta pubblica del 2012, ha messo in luce come i promotori francesi presentassero dati sul traffico in modo strategico per giustificare il progetto. Disaggregando i dati, Ibanez ha dimostrato infatti che il traffico merci tra Francia e Italia era in declino, contrariamente alle previsioni ottimistiche presentate. Anche in Italia esperti locali dell’Osservatorio Torino-Lione hanno criticato i modelli prospettici di crescita del traffico, considerandoli speculativi e distanti dalla realtà storica. I NoTAV italiani hanno infatti sottolineato come l’infrastruttura fosse ingiustificata sia dal punto di vista economico che ambientale.
Il caso della Torino-Lione ha perciò messo in luce le limitazioni dei modelli attuali di governance partecipativa per i grandi progetti infrastrutturali. In particolare, nel caso francese la consultazione non essendo vincolante, può rimanere una consultazione senza sfociare in atti concreti. In Italia invece, il dialogo aperto a posteriori difficilmente avrebbe portato risultati. In entrambi i casi quindi, la governance partecipativa non è stata in grado di promuovere davvero la partecipazione democratica.
Una proposta alternativa è quella della governance deliberativa, che punta a superare la semplice consultazione per favorire un dialogo autentico tra tutte le parti coinvolte, incluse le comunità locali. A differenza dei metodi tradizionali, un approccio deliberativo mira a raccogliere e confrontare idee in modo riflessivo, evitando dinamiche di potere coercitive e creando un terreno di confronto aperto.
Riferimenti
https://academic.oup.com/policyandsociety/article/42/2/259/7017513