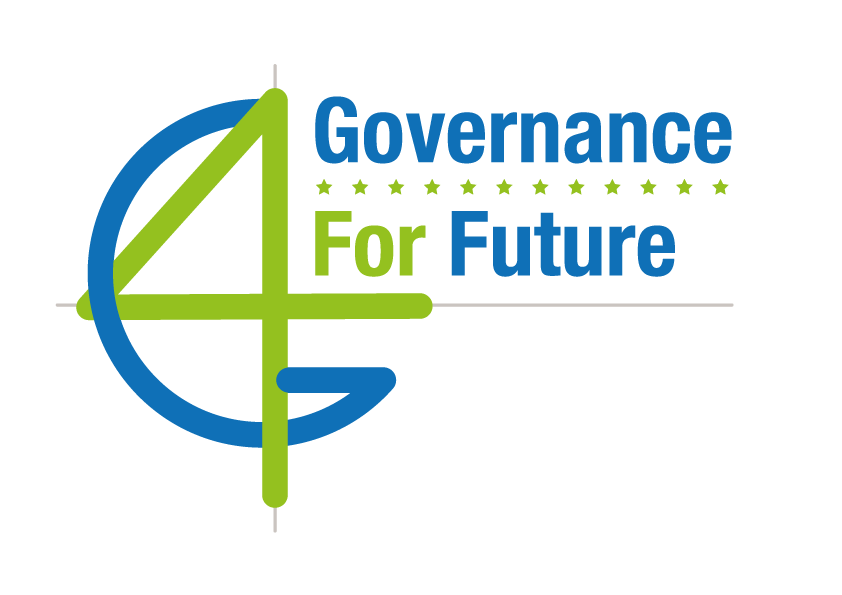Negli ultimi decenni il riconoscimento di diritti specifici per le persone LGBTIQ+, in particolare in riferimento alle unioni tra persone dello stesso sesso, è stato oggetto di evoluzioni in diversi ordinamenti giuridici. Uno sviluppo piuttosto articolato è legato alla legislazione europea, che deve garantire a tutti i cittadini dell’Unione Europea che i rispettivi diritti vengano rispettati, tenendo allo stesso tempo in considerazione la pluralità di sistemi giuridici che la compongono.
Per avere una lettura quanto più chiara del quadro normativo europeo può essere utile un approccio comparato, in cui mettere a confronto sistemi giuridici nazionali, la Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU), e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE). A partire dal principio di uguaglianza, lo step successivo passa per il superamento della discriminazione basata sull’orientamento sessuale, con un particolare focus sul riconoscimento delle unioni same-sex.
I primi passi nel Consiglio d’Europa e la CEDU
I primi passi in direzione di una parità dei diritti LGBTQIA+ nell’Unione Europea si sono mossi sin dagli anni ’80, con la rimozione delle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale da parte del Consiglio d’Europa e la richiesta all’Organizzazione Mondiale della Sanità di rimuovere l’omosessualità dalle malattie mentali, ottenuta il 17 maggio 1990. La Raccomandazione 924 del 1981 chiedeva invece agli Stati membri di depenalizzare l’omosessualità e armonizzare l’età del consenso per rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso.
La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, a partire dalla storica sentenza Dudgeon v. Regno Unito (1981), ha stabilito che la criminalizzazione degli atti omosessuali tra adulti consenzienti costituisce una violazione del diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU). Questa sentenza ha segnato un punto di svolta, stabilendo che i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti senza discriminazioni di sorta.
A sancire il rispetto dell’articolo 8 della CEDU, in riferimento al rispetto alla vita privata, si aggiunge nel 2002 anche la sentenza Goodwin v. United Kingdom, dove ai coniugi, originariamente di sesso opposto e poi same-sex in seguito alla rettifica del sesso di Goodwin, si era imposto lo scioglimento del vincolo. La sentenza riconobbe il diritto di una persona transessuale a formare una famiglia anche dopo la rettifica del sesso di nascita, distinguendo come due distinte fattispecie il diritto al matrimonio e il diritto al riconoscimento dell’unione familiare. Il caso poi, fu un fondamentale spartiacque verso una visone più ampia dell’istituto matrimoniale, in cui il sesso biologico non venne più ritenuto un elemento determinante per potersi sposare e al contempo il diritto alla vita familiare viene riconosciuto a prescindere dal sesso del partner.
Sullo stesso tema in Italia si è discusso con la sentenza 170/2014, in cui al contrario non si riconosceva il diritto al divorzio poiché speculare al matrimonio e quindi, in assenza di leggi sulle unioni civili all’epoca, non era consentita la trasformazione in un altro legame: in questo caso si ritenne la sentenza incostituzionale, e la Corte di Cassazione rimise il caso alla Consulta Europea.

Fonte: Pexels
Oltre il diritto di famiglia: diritti di successione e benefici sociali
Negli anni successivi, la Corte ha ampliato la protezione dei diritti delle persone LGBTIQ+ in casi chiave come Karner v. Austria (2003), dove si è stabilito che la discriminazione tra coppie same-sex e opposite-sex nell’accesso a benefici sociali e ai diritti di successione costituisce una violazione dei diritti umani. In Schalk and Kopf v. Austria (2010), la Corte ha riconosciuto esplicitamente le relazioni omosessuali come parte della vita familiare, sebbene abbia lasciato agli Stati la libertà di decidere se introdurre o meno il matrimonio same-sex.
Fondamentale fu a tal proposito la sentenza Oliari and Others v. Italy (2015), che ha rappresentato un ulteriore passo avanti, affermando che le coppie dello stesso sesso abbiano diritto a una forma di riconoscimento giuridico. La Corte ha ritenuto che l’assenza di un tale riconoscimento in Italia violasse l’articolo 8 CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare. In aggiunta, si è evidenziato come l’art. 8 della CEDU non possa più essere interpretato solo come una protezione rispetto all’interferenza arbitraria dell’autorità nella vita privata, ma debba essere considerato come un obbligo di garanzia del godimento della vita privata e familiare.
Il diritto dell’UE e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea
La CGUE ha svolto un ruolo cruciale nell’espandere il principio di non discriminazione, che attraversa quasi tutti gli ambiti del diritto dell’Unione Europea. L’articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE e l’articolo 10 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea vietano espressamente ogni discriminazione basata sull’orientamento sessuale, mentre la Direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Importantissimo anche l’articolo 19.1 del Trattato di Lisbona, in cui è conferito alle istituzioni europee la possibilità di intraprendere azioni appropriate per combattere la discriminazione.
Sempre in merito ai benefici sociali, in Maruko v. Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen (2008), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che negare a una coppia same-sex il diritto alla pensione di reversibilità costituisce una discriminazione diretta, violando la Direttiva 2000/78/CE. La Corte ha sottolineato che, laddove le unioni registrate offrono diritti simili a quelli del matrimonio, i partner devono essere trattati in modo equivalente. Questa decisione ha segnato una svolta, evidenziando l’importanza di valutare la comparabilità delle situazioni tra coppie same-sex e opposite-sex.
La causa ha dato modo inoltre di approfondire due concetti che sono stati fondamentali anche in seguito per inquadrare le varie forme di discriminazione: la discriminazione diretta, che si verifica nel momento in cui una persona è trattata in modo meno favorevole rispetto ad altre per motivi come religione, handicap, età, orientamento sessuale, ecc., e discriminazione indiretta, che si ha quando una norma, in apparenza neutra, pone una persona in una situazione di svantaggio rispetto ad altre.
In Römer v. Freie und Hansestadt Hamburg (2011), la CGUE ha rafforzato ulteriormente il principio di parità di trattamento, stabilendo che il divieto di discriminazione basato sull’orientamento sessuale è un principio generale del diritto dell’UE e quindi direttamente applicabile in tutto il territorio europeo. La Corte ha chiarito che i benefici sociali concessi ai coniugi devono essere estesi anche ai partner same-sex, laddove le unioni registrate siano giuridicamente equiparabili al matrimonio.

Fonte: Pexels
Il diritto alla libera circolazione
Il rispetto alla vita privata è alla base anche della necessità, evidenziata nel 2000 dal Consiglio d’Europa, di introdurre norme specifiche che riconoscano le coppie dello stesso sesso all’interno degli ordinamenti nazionali, anche per favorire la libertà di circolazione tra paesi: in assenza di tale riconoscimento infatti, sarebbe stato impossibile invocare il diritto al ricongiungimento familiare.
Nel 2003 il Parlamento Europeo ha formulato una proposta inerente alla libera circolazione, per i cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari, secondo la quale a prescindere dal sesso del partner deve essere garantita la mobilità su tutto il territorio europeo. La proposta si basava sul principio per cui se un lavoratore, che in un momento specifico della sua vita si fosse trovato in uno stato diverso rispetto a quello della propria famiglia, non avesse potuto ricongiungersi con i propri familiari, il diritto alla libera circolazione non avrebbe avuto senso.
Al rifiuto della Commissione e del Consiglio europeo fa da contraltare il caso Coman v. Inspectoratul General pentru Imigrați (2018), in cui la CGUE ha affrontato la questione del riconoscimento dei matrimoni same-sex contratti in un altro Stato membro ai fini della libertà di circolazione. La Corte ha stabilito che il termine “coniuge” nella Direttiva 2004/38/CE include i partner same-sex legalmente sposati, obbligando gli Stati membri a riconoscerne lo status per garantire la libertà di circolazione.

Fonte: Pexels
Il consenso europeo e le sfide future
Il principio di uguaglianza ha gradualmente superato le resistenze culturali e giuridiche. Sebbene non tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa abbiano introdotto il matrimonio same-sex, esiste un consenso crescente sulla necessità di riconoscere legalmente tali coppie, determinante nelle decisioni della CEDU e della CGUE.
Nella sentenza Oliari, ad esempio, la CEDU ha osservato che 35 dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa avevano già introdotto forme di riconoscimento legale per le coppie dello stesso sesso e questo consenso europeo ha rafforzato la posizione della Corte nel richiedere agli Stati restanti di adottare misure simili.
Nonostante i progressi, permangono sfide significative. In molti Stati membri, il riconoscimento dei diritti delle persone LGBTIQ+ è ancora oggetto di dibattito politico e sociale. Inoltre, l’applicazione uniforme dei principi stabiliti dalla CEDU e dalla CGUE non è sempre garantita. Ad esempio, in casi come Maruko e Römer, la Corte ha lasciato ai giudici nazionali la responsabilità di valutare la comparabilità delle situazioni, generando potenziali discrepanze nell’applicazione del diritto dell’UE.
Un altro problema è rappresentato dalla tensione tra il diritto dell’UE e le normative nazionali, soprattutto in paesi dove il matrimonio same-sex non è riconosciuto. La sentenza Coman è un esempio di come la CGUE abbia cercato di bilanciare il rispetto per le competenze nazionali con l’esigenza di garantire la libertà di circolazione e la parità di trattamento.
Nel lungo processo di evoluzione dei diritti LGBTQIA+ in Europa, l’inerzia degli Stati membri viene considerata ormai una violazione dei diritti dell’uomo, e le corti europee si sono sostituite di frequente a quelle nazionali, fungendo così non da garante quanto da legislatore.
In definitiva, il sistema multilivello europeo ha svolto un ruolo cruciale nel promuovere i diritti delle persone LGBTIQ+. Attraverso il dialogo tra la CEDU e la CGUE, sono stati compiuti importanti progressi verso il riconoscimento delle unioni same-sex e la parità di trattamento. Tuttavia, restano sfide significative, tra cui l’applicazione uniforme dei principi e la resistenza culturale in alcuni Stati membri.
Il futuro della tutela dei diritti delle persone LGBTIQ+ dipenderà dalla capacità delle istituzioni europee e degli Stati membri di continuare a dialogare e collaborare per superare le discriminazioni e garantire un’effettiva uguaglianza, che vada oltre il riconoscimento di diritti sociali generici e si focalizzi su un riconoscimento mirato delle coppie dello stesso sesso.
Riferimenti
Di Bari_La tutela multilivello delle persone LGBTIQ