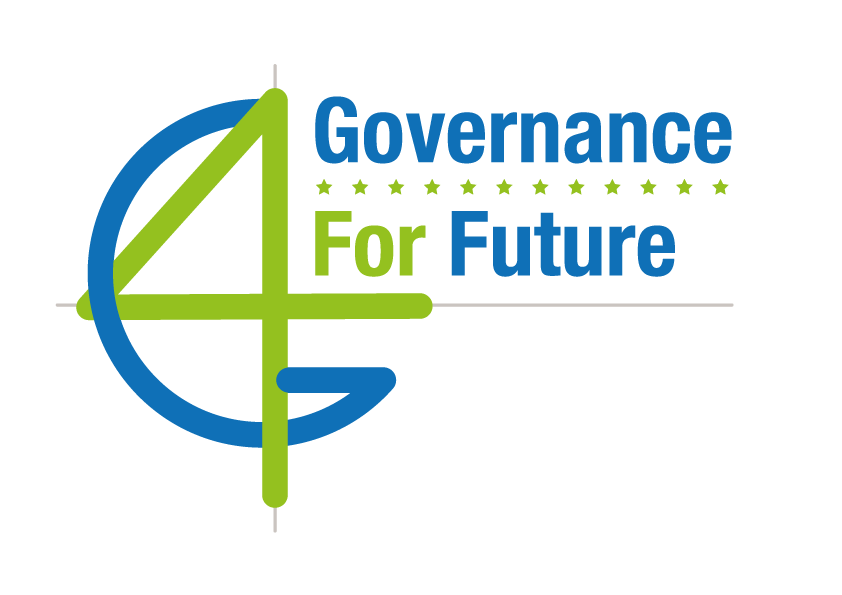- La misinformazione consiste nella diffusione di informazioni false senza intenzione di nuocere, spesso causata da errori o mancanza di consapevolezza, come titoli fuorvianti, virgolettati non pronunciati o collegamenti errati tra fatti.
- La malainformazione riguarda contenuti veri usati con l’intento di danneggiare, come fughe di notizie riservate o discorsi d’odio.
- La disinformazione, invece, implica la creazione e diffusione deliberata di falsità per arrecare danno, ad esempio manipolando il contesto o polarizzando dibattiti complessi.
La disinformazione poi, spesso mette in risalto differenze e divisioni e lo fa per creare ulteriori tensioni nel dibattito pubblico, normalizzando pregiudizi, polarizzare le posizioni, fino a giustificare la violenza.
Questi fenomeni possono intersecarsi: una notizia disinformativa può diventare misinformazione quando viene condivisa inconsapevolmente. Tale complessità richiede risposte giuridiche flessibili per tutelare i diritti individuali, la coesione sociale e la stabilità democratica.
Libertà di espressione: il contrasto tra Stati Uniti ed Europa
La tematica della diffusione di notizie, di qualsiasi natura esse siano, è strettamente legata al concetto di libertà di espressione che anche all’interno del mondo occidentale è oggetto di diverse interpretazioni.
Negli Stati Uniti, la libertà di espressione si fonda sull’idea del mercato delle idee, dove la verità emerge dal confronto tra opinioni, un principio giuridico che deriva dalla dottrina del liberalismo angloamericano e dal pensiero di figure come Milton, Mill e Jefferson: in particolare secondo quest’ultimo, l’opinione errata può essere tollerata se la ragione è lasciata libera di combatterla. Questo approccio, che culmina con la sentenza Brandenburg v. Ohio (secondo la quale uno Stato non può vietare discorsi che promuovono una condotta illecita a meno che tali discorsi non siano diretti a incitare una condotta illecita nell’immediato) protegge un ampio spettro di espressioni, incluso il diritto di contestare opinioni errate o false.
In Europa, la libertà di espressione è bilanciata dalla protezione della dignità umana e dalla prevenzione di discorsi d’odio o pericolosi. La Corte europea dei diritti dell’uomo riconosce la necessità di regolamentare espressioni che possano ledere la dignità o promuovere l’odio, con attenzione al contesto storico e culturale di ciascun Paese. Nonostante non esistano divieti espliciti a vietare la diffusione di fake news, è lasciato agli Stati la possibilità di prevedere sanzioni per i portali di notizie online per i commenti degli utenti ritenuti offensivi o che incitano all’odio o alla violenza.
Le differenze si estendono anche al concetto di privacy, che negli Stati Uniti è legato alla libertà individuale e alla protezione da intrusioni statali, mentre in Europa è radicato nella tutela della dignità e dell’uguaglianza sociale, eredità di società storicamente gerarchizzate. In particolare per l’Europa, lo Stato avrebbe una responsabilità morale di proteggere i propri cittadini, bandendo forme di espressione lesive per la dignità umana: ad esempio, nel caso di particolari situazioni storiche (come richiami al fascismo o nazismo), la limitazione non è vista come una privazione della libertà di espressione ma come una protezione della dignità individuale.
Queste prospettive riflettono le diverse priorità: negli USA, in una società di immigrati in cui non vi è necessità di livellamento sociale, si teme la censura statale e quindi il soggetto censore, mentre in Europa prevale il timore di discorsi nocivi per la società, ovvero il messaggio.
Il compromesso tedesco della Netzwerkdurchsetzungsgesetz
La legge tedesca Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG), introdotta nel 2017, rappresenta un tentativo di bilanciare due visioni molto diverse sulla libertà di espressione e la regolamentazione del discorso online. Da un lato, si ispira alla tradizione giuridica europea, che privilegia la tutela della dignità e dell’uguaglianza dei cittadini, e dall’altro tiene conto della sensibilità americana, più attenta alla difesa della libertà di parola da interferenze statali.
La NetzDG obbliga i social network con più di due milioni di utenti in Germania a gestire le segnalazioni di contenuti illeciti in modo rapido ed efficiente. I contenuti manifestamente illegali devono essere rimossi entro 24 ore, mentre quelli più complessi possono essere analizzati entro sette giorni. Le piattaforme devono inoltre conservare i contenuti rimossi per dieci settimane e notificare la loro decisione sia al reclamante che al segnalato, spiegandone le motivazioni.
Questa impostazione lascia alle piattaforme una discrezionalità significativa nel decidere quali contenuti rimuovere, trasformandole, in pratica, in una sorta di “agenti dello Stato”. Ciò ha suscitato critiche sia negli Stati Uniti, dove si teme un’indebita interferenza governativa nella libertà di espressione, sia in Europa, dove si denuncia una scarsa supervisione pubblica sulla censura privata.
Dal punto di vista pratico, i dati raccolti finora mostrano un aumento delle segnalazioni, ma un calo nel tasso di rimozione dei contenuti, suggerendo che le piattaforme non abbiano adottato un approccio eccessivamente restrittivo (overblocking). Inoltre, il sistema sembra aver trovato un equilibrio tra il contrasto ai discorsi d’odio e il rispetto della libertà di espressione, anche se permane il dibattito sulla sua efficacia e sul ruolo dello Stato nella regolamentazione dei contenuti online.

Fonte: Pexels
La dignità a fondamento della libertà di espressione nella legislazione statunitense
Negli Stati Uniti dunque, l’accettazione delle ingerenze statali passa per il concetto di dignità, anche se non compare esplicitamente nella Costituzione. Questo termine, che ha molteplici significati, è stato spesso richiamato per bilanciare il diritto alla libertà di espressione con la necessità di proteggere la dignità degli individui, soprattutto in casi di discorsi d’odio.
Ad esempio, la Corte ha ritenuto costituzionale una legge contro la diffamazione che protegge i cittadini da contenuti che li esporrebbero al disprezzo per motivi di razza, religione o altre caratteristiche personali. Tale approccio trova conferma in recenti decisioni, come nel caso Chen v. Albany School District, dove i giudici hanno sostenuto la validità di sanzioni disciplinari contro studenti che, tramite post sui social media, avevano pubblicato contenuti razzisti e violenti. Nonostante le espressioni incriminate fossero state condivise al di fuori dell’orario scolastico, i loro effetti dannosi hanno giustificato l’intervento disciplinare, con la Corte che ha sottolineato il valore educativo della dignità e del rispetto nelle scuole.
Allo stesso modo, il concetto di dignità è emerso in casi come Virginia v. Black, in cui la Corte ha dichiarato incostituzionale una legge che vietava di bruciare croci come atto intimidatorio. Pur riconoscendo il carattere minaccioso di tali condotte, la Corte ha sottolineato che la libertà di espressione va limitata solo quando si può dimostrare una chiara intenzione intimidatoria. Questa distinzione evidenzia come la dignità possa essere utilizzata per bilanciare il diritto di espressione con la protezione delle persone contro minacce o offese gravi.
In sintesi, sebbene negli Stati Uniti la libertà di espressione sia fortemente tutelata, la giurisprudenza della Corte Suprema ha riconosciuto che in alcuni casi è necessario limitarla per proteggere la dignità individuale. Questo equilibrio, tuttavia, richiede una definizione chiara e condivisa del concetto di dignità, che nella giurisprudenza americana può essere declinato in diverse forme: uguaglianza, libertà, integrità personale o virtù collettiva.
Hate speech e fake news: tra libertà di espressione e sfide democratiche nell’era digitale
La libertà di espressione ha subito un’espansione significativa nel corso del XX secolo, ma l’avvento di Internet ha introdotto nuove sfide, come il problema di valutare i contenuti decontestualizzati rispetto alla legislazione locale. Questo è particolarmente rilevante per fenomeni come hate speech e fake news, che non solo danneggiano individui e gruppi specifici, ma minacciano anche la stabilità dei sistemi democratici.
Un punto centrale del dibattito odierno è rappresentato dalle piattaforme social e dalla loro gestione dei contenuti controversi, come dimostrato dal caso del ban di Donald Trump. La questione ruota attorno a come bilanciare libertà di espressione e tutela dei valori democratici, in un panorama dove i confini tra le due sono sempre più sfumati. L’approccio differisce tra le due sponde dell’Atlantico, rendendo complesso un compromesso tra le tradizioni giuridiche occidentali.